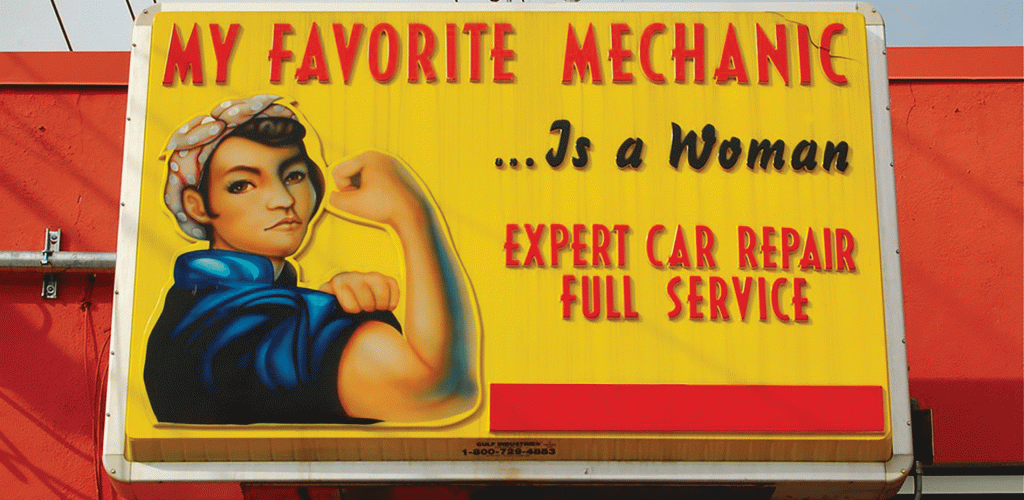Quando si parla di gender gap, la cultura USA è un laboratorio legislativo unico al mondo per la sua capacità di innovare mantenendosi, allo stesso tempo, ancorata a un credo economico conservatore in diverse sue applicazioni. Multiculturalità e difesa dell’autodeterminazione individuale hanno inoltre allargato ulteriormente il campo d’azione del confronto uomo-donna (si pensi alla comunità LGBTQ).
Che le cose lì fossero piacevolmente diverse lo capii già durante il mio primo anno negli States, nel ‘93, quando mi sorprese scoprire che il tecnico che stava svolgendo un intervento di manutenzione a un palo della luce era donna. Rimasi affascinato dalla disinvoltura con cui si muoveva sospesa in aria: e d’altra parte perché non si sarebbe dovuta comportare così? Era il suo lavoro. Qualche mese dopo, ebbi la conferma di questa straordinaria differenza con il nostro Paese quando accompagnai il mio amico dal suo meccanico, anche lei donna, brava e competente. Mi sentii proprio felice di essere parte di una società così evoluta, dove ciascuno potesse esprimersi e realizzarsi indipendentemente dal genere!
Come sempre, però, non è oro tutto ciò che luccica. Sulla questione gender gap, infatti, gli Stati Uniti non hanno ancora totalmente ratificato una direttiva internazionale emessa più di 100 anni fa dalla League of Nations sul diritto delle lavoratrici a un periodo di assenza remunerata di almeno 12 settimane (paid maternity leave) per preparare al meglio pre- e post-parto. Mentre tutti i Paesi occidentali hanno esteso sempre di più quella prescrizione sul periodo di assistenza (71 settimane in Svezia, 50 in Canada, 40 in Inghilterra, ecc.), gli USA sono riusciti, solo nel 1994, sotto la spinta innovativa della prima amministrazione Clinton, a far passare una legge, il Family and Medical Leave Act, che riconosce alla donna un periodo di 12 settimane (non retribuite) in cui potersi assentare dal lavoro per varie ragioni (tra cui anche la maternità), con la garanzia di ritrovarlo alla fine dell’assenza.
Né il settore privato ha mai corretto il tiro: secondo una recente ricerca della Kaiser Family Foundation, solo il 25% delle aziende statunitensi ha un programma che preveda ulteriori forme di assistenza durante il periodo di maternità. Per il Dipartimento Federale del Lavoro, anzi, tale condizione “volontaria e straordinaria” è spesso oggetto di trattativa contrattuale (privata), come fosse un benefit o un privilegio per chi se lo può permettere per status (quadri aziendali o élite culturali).
Con queste premesse poco confortanti, è facile immaginare in che tipo di cultura aziendale e sotto quali pressioni una donna americana si trovi a operare per sviluppare valore per sé e per l’azienda. Concentrare l’impegno contro il gender gap su livelli superiori di applicazione (parità remunerativa, eguali opportunità di entrata nel mondo del lavoro, ecc.) senza passare dalla radice civile più profonda, potrà solo essere per gli States un cerotto normativo “monco”, non sostenuto da una base di diritto che, ad esempio in Italia, è considerata da tutti “scontata e inalienabile”. E non è un caso, infatti, che continuino a esistere interi settori produttivi o intere categorie d’impiego dove l’essere donna significa troppo spesso non essere madre o non sentirsi nella condizione di poterlo serenamente essere.
E tutto ciò non dovrebbe essere percepito come una battaglia “femminista”, ma semmai come una chiamata civile per la salvaguardia dei “diritti umani” fondamentali, in questo caso anche essenziali per il proseguimento (naturale e non ideologico) della specie. Questa è una di quelle tematiche che coinvolge tutti, con la felicità dell’uno strettamente vincolata a quella dell’altro e la vera innovazione, prosperità e crescita che passano dalla felicità condivisa. È come si dice da secoli in Africa: UBUNTU.