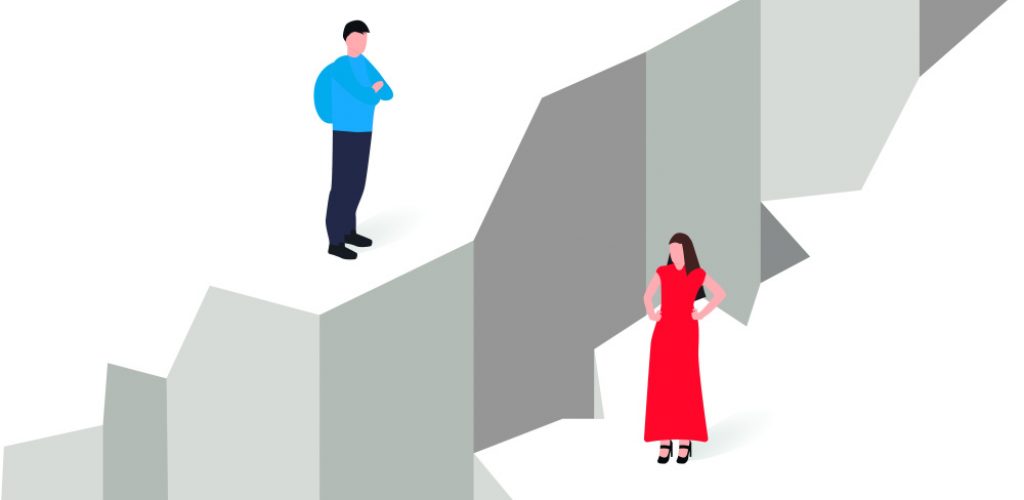Probabilmente è anche un po’ colpa del mio editoriale se questo numero esce con quasi un mese di ritardo. Il tema è complesso e non credo che serva un altro uomo (aggiungerei ahimè di mezza età) per parlare di un tema che vede nel nostro paese un basso tasso di occupazione (in Italia lavora meno di una donna su due), alta percentuale di contratti part time (49,8%), elevata differenza salariale (stimata nel 5,6% dal Wef, ma per altre rilevazioni Eurostat al 12%), mancata possibilità di carriera (solo il 28% dei manager sono donna, peggio di noi in Europa solo Cipro) e accesso a formazione Stem (16% delle donne contro il 34% degli uomini). Io vorrei semplicemente riportare in questo editoriale, che anticipa interventi ben più prestigiosi, tra cui la Vicepresidente degli Stati Uniti D’America Kamala Harris e la Ministra Bonetti, alcune voci di amiche e conoscenti e le difficoltà che hanno incontrato nel loro percorso professionale.
La prendo un po’ alla lontana e parto da mia figlia Chiara, 7 anni, che quest’anno ha scelto come sport il Calcetto. La cosa incredibile è che ancora oggi questa decisione ha avuto reazioni strane tra bambini e genitori. La cosa incredibile però è vedere come questo sentimento, anche non con cattiveria, sia fatto anche da persone di alta istruzione e indifferentemente dal genere. Un’amica constatava di quanto fosse naturale l’amore dei figli maschi per il calcio e quanto invece le figlie fossero attratte da altri interessi, senza minimamente prendere in considerazione la natura sociale del nostro paese.
Mi soffermo su questo argomento perché è quello che mi ha colpito di più. Chi conosce un pochino gli Stati Uniti, ad esempio, sa che il calcio lì è uno sport a prevalenza femminile. La nazionale di calcio USA è la più forte al mondo, proprio perché fin da bambine le ragazze vengono educate a questo sport, e spesso i “maschietti” che vogliono farlo vengono anche presi in giro perché non praticano football americano.
È cambiata la frase. A distanza di sole dieci ore di volo, o qualche migliaio di Km che dir si voglia. Eppure c’è solo una frase saggia che ho sentito su questo argomento e l’ha detta mia figlia Martina (9 anni e mezzo) a un bambino che le diceva che non poteva giocare ad un gioco perché da maschio: “NON ESISTONO COSE DA MASCHI E COSE DA FEMMINE”. Qui, oltre all’orgoglio di papà, di due figlie che crescono, spero, con sani principi, emerge chiaramente ciò che oggi influenza in maniera negativa la reputazione di un’organizzazione: lo stereotipo di genere.
Il termine stereotipo deriva dal greco: stereòs = rigido e topòs= impronta. Lo stereotipo è un insieme di pregiudizi, credenze, rappresentazioni ipersemplificate della realtà e opinioni rigidamente connesse tra di loro che un gruppo sociale associa a un altro gruppo. La nostra cultura di rappresentazione del maschile e del femminile è assolutamente intrisa da stereotipi con i quali finiamo per attribuire determinate caratteristiche agli uomini e alle donne senza esserne nemmeno consapevoli e questi rappresentano la principale legittimazione alla violenza di cui sentiamo parlare ogni giorno e che interessa le strade e le case d’Italia.
Credenze e opinioni senza dubbio semplicistiche ma profondamente assunte e culturalmente rafforzate sulle caratteristiche degli uomini delle donne.
«Gli stereotipi sono come l’acqua per i pesci: proprio perché ci circondano e sono ovunque, non li vediamo più.» (Foster Wallace).
Per combattere in maniera efficace la violenza sulle donne occorre necessariamente partire dallo sradicamento di questo modo di ragionare e riflettere su tanti comportamenti che potrebbero sembrare normali, ma che in realtà non lo sono affatto, e provare a estirparli del tutto.
Ne ho parlato ad esempio con Marina, neurochirurgo, ambito dominato storicamente da uomini, che ha provato a semplificarli in tre modelli:
- Uomini che pensano proprio che una donna non possa svolgere questo lavoro (pochi).
- Uomini che credono che le donne non siano assolutamente da meno, ma che per contingenze familiari non possono dare tutta la loro disponibilità (la maggior parte).
- Uomini che non fanno distinzione (e si contano sulle dita di una mano).
Lei mi ha detto “il problema non è solo in Italia, pensa che un importante programma di formazione europeo che prevede un corso di 4 giorni per 4 anni consecutivi, al quale si accede solo per selezione, non ha accettato la richiesta mia e di altre colleghe di spostamenti per maternità, e alla richiesta di chiarimenti è stato ribadito che, chi vuole partecipare al corso, deve considerare che per 4 anni non deve mettere in cantiere un figlio. La cosa brutta è che ti fanno credere fin dagli studi che la carriera di neurochirurgia non sia compatibile con una potenziale famiglia, ma questo vale ovviamente solo per le donne”
Mi avevano già a suo tempo aiutato le parole di una mia amica, giornalista professionista, attualmente impegnata al Governo “Il predominio del genere maschile nel mondo delle imprese e delle organizzazioni, ha portato a descrizioni delle mansioni e a un’organizzazione del lavoro conformi esclusivamente ad un’ottica maschile: pensate da uomini, per uomini.”
Per questo motivo gli stereotipi nel mondo del lavoro sono tipicamente sessisti, ovvero descrivono un’immagine femminile ed esprimono giudizi che non appartengono ad entrambi i generi, ma sono stati determinati solo da uno, quello maschile.
Raffaella, avvocato penalista: “Nella professione di avvocato penalista il problema è tanto più grave in quanto si inserisce in una situazione di crisi generale della professione negli ultimi anni. Il ramo penale, già di per sé grava di più sulle donne: non ha orari, si viaggia molto, e si ha istintivamente meno fiducia nel rivolgersi ad una penalista. Inoltre, c’è anche un grosso problema di gap retributivo” Ho trovato molto significativa questa testimonianza: “Un cliente mi disse: «grazie avvocato…preferisce avvocato o avvocatessa? Sa, lei ha così tanti ”attributi” da invertire persino la classica distinzione uomo-donna… a proposito, come
stanno i bambini? Questa frase è forse la summa. A me non interessa essere chiamata avvocatessa. Penso che il termine avvocato, in un mondo ideale, individui la professione e non il genere della persona che lo pratica. Il problema è che è proprio il titolo a non essere riconosciuto. Vieni chiamata signorina o dottoressa anche dopo 18 anni di professione. Ma il problema più grande è quello retributivo: secondo i dati del Censis il reddito medio degli uomini è di 54.500 €, quello delle donne è di appena 25.072 € mentre sui redditi più alti, di chi guadagna oltre i 100.000€ annui solo il 15,4% è donna. La cosa che fa realmente riflettere è come nel percorso formativo non ci sia lo stesso gap. Anzi, a livello universitario, le donne sono più degli uomini, prendono voti più alti e vanno meno fuori corso. Insomma il problema è puramente sociale.”
Un’altra mia amica, ispettrice di Polizia, ambiente in prevalenza composto da uomini, dopo avermi specificato come non avesse mai rilevato grossi problemi in quanto a gender gap e che, in fondo, fin dall’accademia la percentuale di donne fosse altissima, ha però poi preferito non inserire neanche il suo nome per evitare di essere riconosciuta. Diciamo che se c’è una sola persona in Italia con il tuo nome e il tuo grado in Polizia, mi sa che qualche problemino di gender gap è più che presente. Quello che mi ha detto è forse una storia comune però a tanti lavori “Bisogna entrare in punta di piedi, e farsi conoscere a poco a poco, si ha l’impressione che bisogna dimostrare più di un collega di sesso maschile e fare in modo che ti apprezzino più per le tue capacità che per il tuo aspetto”.
Alessandra, dirigente di un sindacato, ha provato ad argomentare meglio il tema dell’aspetto, ovvero “il problema della donna è che invece di lavorare lei per prima sul proprio merito e talento, si sofferma sui propri stereotipi, piaggerie e comportamenti che afferiscono a driver dell’estetica e dell’accondiscendenza nei confronti degli uomini, per fare carriera. Ovvero tutto ciò che avalla gli stereotipi sociali collettivi”
Alla fine, provando a capire, a studiare e a parlare con tante amiche mi rendo conto di come una delle cose più preoccupanti di questo tipo di pregiudizi sia proprio il modo in cui vengano assimilati dalle donne, fin dall’età educativa, e finendo per diventare parte integrante della loro identità.
Quindi, inaspettatamente ho potuto osservare come spesso siano le donne stesse, pur vittime di una cultura che le limita lavorativamente e nella società, a trasmettere stereotipi sessisti ai propri figli (sia maschi che femmine) e alle generazioni successive.
Così giungiamo al punto cruciale di questo articolo: vi è modo di distinguere, con il minor margine possibile, quali delimitazioni e comportamenti in ambienti lavorativi siano determinati da stereotipi e quali giustificati da una reale differenza dei sessi? L’impatto positivo della parità di genere all’interno delle aziende non riguarda solo tematiche di compliance e responsabilità sociale, ma impatta positivamente sulla Reputazione dell’azienda. Non è quindi solo un discorso di “buone intenzioni” bensì, di avere un ulteriore strumento per impattare positivamente sul proprio fatturato a medio termine.
Un’azienda con una gender equality reale è più capace di attrarre e trattenere i talenti e le risorse umane migliori, di migliorare la fidelizzazione dei clienti, di essere più innovativa, di raggiungere alti livelli di soddisfazione del personale e di garantire, infine, livelli di delega adeguati. Quindi, oltre ad essere un importante tema sociale da perseguire, diventa anche una tematica urgente per intervenire all’interno della propria organizzazione. Ne va della sua sopravvivenza.